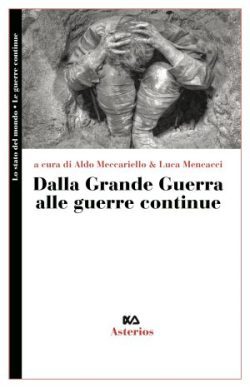Dopo che il prof. Gennaro Cicchese, Presidente Nazionale dell’A.D.I.F. ha passato in rassegna, con dovizie di spunti, suggerimenti di letture e di visioni cinematografiche, i diversi articoli del numero della rivista, allargando il campo documentario della Grande Guerra, ritengo infruttuoso un intervento che percorra la stessa strada, pure necessaria e, in qualche modo, propedeutica a quanto sto per proporre. Vorrei infatti tentare un altro itinerario, e, partendo da pochi, ma significativi passi di alcuni degli articoli presenti nella Rivista, schizzare alcune prospettive verso cui l’insieme della riflessione offerta dalla Rivista sembra muoversi. Mi limiterò a tre punti.
Per il primo punto muovo da una considerazione poco nota. Sul finire della Grande Guerra nacque un po’ ovunque in Italia, ma specie nel Meridione, un modo di dire, un’offesa. Era questa: «Sei uno scemo di guerra!». Ciascuno lo declini nel proprio dialetto. L’espressione scemo di guerra prima non esisteva, e faceva duramente riferimento a tutti quei soldati che, tornati dai vari fronti, erano rimasti segnati malamente da un’esperienza che li aveva scimuniti appunto: nelle loro persone si faceva visibile l’esperienza dell’insostenibilità di una Grande Guerra che qualcun altro, papa Benedetto XV, in contropelo, per così dire, battezzò come «inutile strage». Mi chiedo cosa fosse insostenibile. Prendo spunto dall’articolo di Pierandrea Amato, il quale scrive:
«Il primo conflitto mondiale corrode la civiltà dell’illuminismo e dà vita a un immenso scannatoio in grado di evocare le guerre di religione, i macelli medioevali; ma tutto ciò è ordito, ed è questa la novità, su scala industriale. Le trincee, le guerre di posizione e di materiali, sono i nomi di un paesaggio in cui si consuma l’integrazione tra la vita e la macchina, la morte e i dispositivi tecnici […] si schiude un’epoca in cui si progetta l’inesorabile marginalizzazione dell’uomo nel suo stesso mondo, perché la tecnica diventa, per paradosso, il nome dell’incalcolabile […]. La Grande Guerra, in effetti, è il nome della materializzazione di un principio romantico che attraversa e determina i lineamenti della modernità: la perdita di misura, il dominio del troppo grande»[1].
La civiltà dell’illuminismo viene corrosa perché la pretesa di estendere la critica e la guida della Ragione – con la maiuscola! – a tutti i campi dell’esperienza umana non si rivela troppo modesta, ma eccessiva. Si tratta di ciò che Michele Schiff, definisce la «catastrofe di una razionalità ormai dimentica di sé», precisamente nel senso che, paradossalmente, «la guerra diventa l’aspetto più irrazionale prodotto dalla ragione stessa nelle sue pretese assolute»[2]. La tecnica, il macchinico, lo strategico, come prodotti della Ragione totalizzante, diventano i protagonisti della Grande Guerra, lì dove la Ragione, nel suo delirio di onnipotenza, perde la misura, sconfina nell’incalcolabile di una violenza impersonale distruttiva, che si fa umanamente insostenibile, perché insensata.
L’ipertrofia della Ragione calcolante, che Martin Heidegger presenterà in quel testo assoluto che è La questione della tecnica, evidenzia la trasformazione del regime ontologico di ogni cosa, uomo compreso, in Bestand, in pura risorsa, funzionalizzata a quell’apparato onnipervasivo che Heidegger chiama il Ge-stell, ciò che com-pone e dis-pone le risorse in una organizzazione totalizzante, in base alla quale le cose prendono senso, appunto, come Bestand, e guadagnano – udite! udite! – la salvezza[3]. Non sembri un’affermazione esagerata! Sarà proprio il Ge-stell, ciò che poi Jacques Ellul chiamerà il sistema tecnico, e Jean-Luc Nancy, l’ecotecnica (solo per citare alcuni dei nomi possibili), ciò che prenderà il posto di quella dispositio provvidenziale e quella ancora più remota oikonomia della salvezza che precedentemente erano state cristiane. La riflessione di autori come David F. Noble, Giorgio Agamben, e, più recentemente, Mauro Magatti, è illuminante nel ripercorrere la storia della relazione tra religione e tecnica, nel loro intrecciarsi con economia e politica.
Ma questa situazione avrà il suo risvolto positivo,e questo mi interessa sottolineare, perché obbligherà la filosofia a guardare altrove per riscoprire l’umano dell’uomo, non giudicato sub specie technae. Sono proprio gli anni immediatamente precedenti alla Grande Guerra che vedono la nascita del pensiero attorno alla Lebenswelt, al mondo-della-vita. Sulla scia del mondo naturale di Avenarius, infatti, Edmund Husserl, già nel corso del 1910-1911, dal titolo Lezioni sul concetto naturale di mondo, svilupperà la distinzione tra il sapere riflesso delle scienze e il sapere irriflesso del vissuto. Sono questi gli anni in cui Martin Heidegger getta le basi per la sua ermeneutica della fatticità, e alcuni dei filosofi analitici, come Moore, si rivolgono allo studio del linguaggio ordinario e alle “ovvietà” del senso comune, contro gli specialismi di una filosofia accademica dimentica del reale. Questa svolta verso il mondo della vita ordinaria è difficilmente sottovalutabile, poiché individua un campo di realtà da cui la scienza e la tecnica dipendono, aprendo, sia pure solo da qualche tempo, la ricerca intorno all’embodiedcognition che sta avendo ricadute non marginali sul modo di concepire la ricerca scientifica e le sue applicazioni tecniche.
Il secondo punto lo colgo nel prezioso articolo di Emilio Baccarini. Il pensiero di Lévinas è noto. Quello di Eric Weil meno. Ma è proprio questo autore, che, per quanto letto nell’articolo, merita di essere approfondito, poiché fa della razionalità umana, o forse della ragionevolezza umana (più in linea con il mondo della vita), non già un dato che è proprio di homo sapiens, come voleva la tradizione dell’animal rationale aristotelico-scolastica, e non solo, ma una vocazione: «il senso dell’uomo è affidato a una volontà di senso […]. Per lui essere ragionevoli è un compito»[4]. Questo compito si scontra continuamente con un’alternativa che si genera dallo stesso suolo della ragione, quella della violenza, che resta una opzione per l’uomo che «ha la possibilità di rifiutare il logos, il discorso ragionevole, e anche di fornire le “ragioni”, le motivazioni, di questo rifiuto»[5]. Solo grazie alla ragione, la violenza può trovare ragioni che la legittimino, sia pure sfociando, come visto, nella perdita della misura, nell’insensato. Sicché il discorso dell’uomo filosofo non può che essere sempre «discorso della violenza e sulla violenza»[6], affinché le ragioni della violenza vengano smascherate in un esercizio di demistificazione, ed essa si mostri per quello che è, scomparendo dal mondo[7]. Questo sforzo, per Weil, non si risolve tuttavia in una vuota verbosità accademica. Piuttosto «la ragione come “forza” non è altro che l’azione ragionevole […] la capacità di scendere sul terreno della violenza che è [….] il nostro terreno, il mondo della vita e modificarlo, “formarlo”, elaborarlo in vista della non-violenza»[8]. La ragionevolezza umana è così una vocazione ad essere operatori di pace, ad essere costruttori di un mondo che, pur non potendo rifiutare la tecnica, non ne faccia la misura di tutte le cose, e lasci la possibilità, per dirla con Lévinas, che il volto e la parola di Autrui accada ancora nella vita vissuta di ciascuno.
Rispetto a questa vocazione alla ragionevolezza, produttrice di pace, concludo questo intervento con un terzo punto di riflessione, guardando al futuro così come ce lo prospetta l’articolo di Igor Škamperle, Ripensare la Grande Guerra, nel quale la vocazione alla pace si allarga all’Europa. Come egli sostiene a p. 24:
La storia umana non è finita. Ma nemmeno le sfide del mondo e del progresso delle società sono finite. Parlando di Europa, della Grande guerra e della crisi che allora come oggi impegna il nostro pensiero, possiamo costatare che la piccola Europa, dopo le sue gloriose avventure umane di arte e pensiero, ma anche dopo le tragiche esperienze belliche, ha ancora qualcosa da dire al mondo. Può manifestare la sua peculiare forma di spazio sociale e culturale comune delle molte patrie, che gli Stati Uniti, la Cina e i paesi dell’Africa forse non riescono a manifestare.
Per quanto capisco la storia ci spinge verso lo sfarinamento di ciò che da qualche secolo si chiama tolleranza, termine che, almeno in italiano, ha una sfumatura assiologica negativa, per tornare ad un progetto più antico e contemporaneamente più nuovo, quello di una concordia, alla quale siamo chiamati come europei,“esperti di umanità” per le nostre radici cristiane,e come abitanti di un mondo (inteso sia come natura che come società umana) in cui non possiamo più permetterci il lusso di ignorare chi ci sta affianco e condivide il nostro stesso destino storico di uomini del terzo millennio.
NOTE
[1] P. Amato, Orrore e rappresentazione: 1914, in «Per la filosofia», 2017, p. 80.
[2] M. Schiff, Introduzione, p. 14.
[3] M. Heidegger, La questione della tecnica, 1953.
[4] E. Baccarini, Pensare la pace con Eric Weil ed Emmanuel Lévinas, p. 53.
[5] Ivi, p. 55.
[6] Ivi, p. 57.
[7] Idem.
[8] Ivi, pp. 58-59.
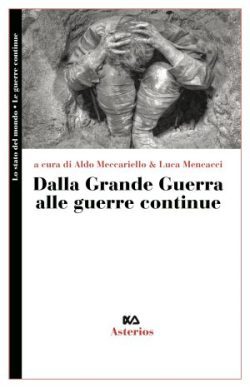 Clicca sul link, visita la pagina del volume nel sito di asterios e se desidera ordina il volume!
Clicca sul link, visita la pagina del volume nel sito di asterios e se desidera ordina il volume!
https://www.asterios.it/catalogo/dalla-grande-guerra-alle-guerre-continue